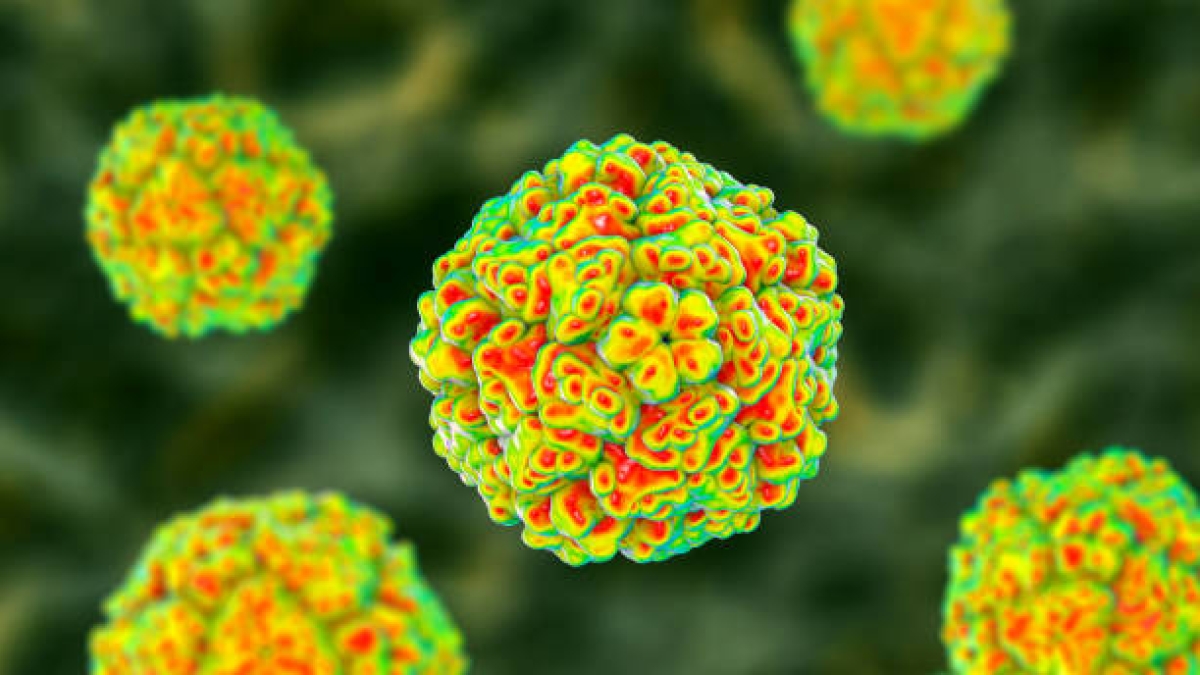Li temiamo considerandoli nemici da sconfiggere. Ma oggi gli oncologi cercano di aggiungerli all’arsenale di «armi terapeutiche» per trattare il cancro. Parliamo dei virus oncolitici: una revisione pubblicata, a settembre, nell’edizione 406 di The Lancet ripercorre decenni di studi su questi agenti, naturali o ingegnerizzati, capaci di replicarsi selettivamente nelle cellule tumorali e stimolare il sistema immunitario a riconoscerli e distruggerli.
Che cosa sono i virus oncolitici
«Un virus oncolitico entra nelle cellule tumorali attraverso una chiave specifica e attiva processi di morte cellulare dall’interno. In questo modo libera frammenti del tumore che diventano “bandierine” riconoscibili dal sistema immunitario. Così il nostro organismo impara a individuare e attaccare meglio le cellule malate» spiega Mario Scartozzi, professore di Oncologia all’Università degli Studi di Cagliari.
L’idea parte dagli Anni Sessanta, quando l’immunologa lettone Aina Muceniece ha osservato che alcuni echovirus (enterovirus a Rna a singolo filamento positivo) erano in grado di infettare e distruggere le cellule del melanoma, una neoplasia ad alta capacità infiltrativa. Uno di questi virus, ECHO-7, inoculato in un piccolo gruppo di pazienti con tumore in stadio avanzato, si è mostrato capace di ridurre la gravità della malattia. Il risultato è stato accolto con cautela, ma ha aperto la strada a studi successivi su campioni più rappresentativi della popolazione.
Dieci anni di avanzamenti
Gli autori della review rimarcano le tappe storiche principali che vedono i virus oncolitici impiegati come farmaci: dall’approvazione dell’Fda, nel 2015, del talimogene laherparepvec (derivato da Herpes simplex di tipo 1 ingegnerizzato) per il melanoma avanzato, a quella del teserpaturev, anch’esso un Herpes simplex di tipo 1 modificato, in Giappone nel 2021 per gliomi ad alto grado di malignità, fino al nadofaragene firadenovec, ricavato da un adenovirus, approvato negli Stati Uniti nel 2022 per il carcinoma vescicale non muscolo-invasivo resistente al Bacillo di Calmette-Guérin (il trattamento d’elezione). «Oltre a colpire in modo selettivo le cellule tumorali, i virus oncolitici rendono il microambiente più visibile al sistema immunitario, amplificando l’effetto degli attuali trattamenti immunoterapici. Le combinazioni con immunoterapie già disponibili mostrano segnali incoraggianti, soprattutto nei pazienti refrattari, aprendo scenari fino a poco tempo fa impensabili», prosegue Scartozzi.
Il nodo della sicurezza
Sebbene le evidenze in laboratorio siano entusiasmanti, i virus possono mutare, come ha dimostrato l’esperienza con SARS-CoV-2 (un coronavirus). Tornano agli oncolitici, la somministrazione concomitante di farmaci potrebbe potenziarne la diffusione, coinvolgendo cellule non ancora intaccate dalla neoplasia. Inoltre, paradossalmente, le concentrazioni virali necessarie per lisare il tumore potrebbero essere elevate al punto da danneggiare le cellule sane.
Il legame indissolubile con le terapie tradizionali
Le interazioni dei virus oncolitici, talvolta, possono essere interessanti. Un vantaggio chiave deriva da quelle con gli inibitori dei checkpoint, farmaci che prendono in contropiede le strategie adottate dal cancro per proliferare. In condizioni di normalità, il sistema immunitario impone dei freni affinché i linfociti T non agiscano in modo sregolato, con il rischio di danneggiare i tessuti sani. Le cellule neoplasiche, nel tempo, hanno affinato strategie per sfuggire a questi controlli. «Se combinati ai virus oncolitici, questi farmaci hanno dimostrato di poter riattivare il sistema immunitario contro il tumore», sottolinea Scartozzi. Anche radioterapia e chemioterapia possono incrementarne l’efficacia, stimolando il sistema immunitario e riducendo il rischio di resistenze.
«Si tratta di dati ancora precoci e limitati, ma sui quali vale la pena investire». Le sfide future consistono nello sviluppare studi più precisi ed eterogenei sull’efficacia virale. I ricercatori ritengono consigliabile l’impiego dei virus nelle fasi iniziali di malattia (terapia neoadiuvante e adiuvante), in pazienti fragili o con comorbidità multiple, o in tumori difficili da raggiungere, come quelli che superano la barriera ematoencefalica. L’Intelligenza artificiale, infine, ha il potenziale di rendere i test più affidabili, rapidi e veloci. Curioso come, in medicina, i nemici possano trasformarsi in alleati.
Fonte: Corriere Salute